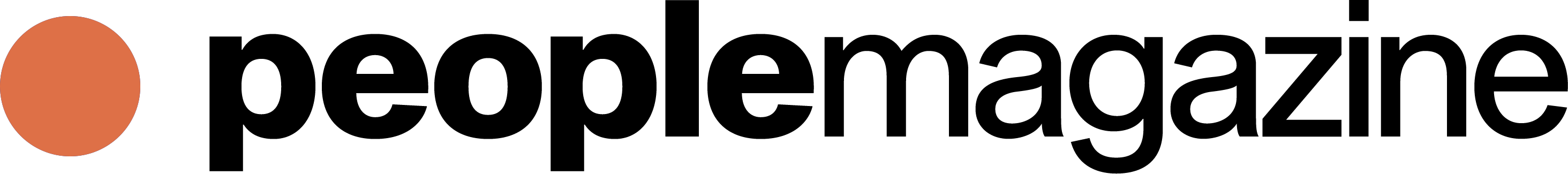Il dibattito sulle “generazioni” è ovunque: giornali, social, meeting aziendali. Spesso però quella parola funziona come una scorciatoia comoda — uno slogan pronto all’uso che appiattisce storie diverse e alimenta luoghi comuni. Meglio guardare la questione con più attenzione: dietro l’etichetta ci sono vite, contesti e opportunità molto differenti.
Perché la categoria “generazione” inganna
Molti usano “generazione” come un bollino che racchiude presunte caratteristiche condivise. È comodo per campagne di marketing o per titoli ad effetto, ma perde di vista le differenze reali: età, luogo, settore professionale, tipo di contratto e storia familiare segnano percorsi molto diversi. Fare di tutta l’erba un fascio significa rendere più difficile capire chi ha bisogno di quale intervento.
Non esiste una “generazione perduta”
La narrazione che dipinge i giovani come tutti precari, sfiduciati e bloccati è semplicistica. Ci sono giovani con stabilità lavorativa e salari dignitosi, e altri intrappolati in lavori atipici e paghe basse. Ridurre tutto a “generazione X” o “millennial Y” nasconde queste disuguaglianze interne e impedisce politiche mirate.
Quello che conta davvero
Se vogliamo politiche efficaci servono dati disaggregati: indicatori territoriali, settoriali e contrattuali. Occorre considerare istruzione, rete sociale, residenza, e le politiche locali che aprono o chiudono opportunità. La disoccupazione giovanile non è una colpa culturale: è il risultato di scelte economiche, investimenti pubblici e modelli produttivi che spesso premiano la flessibilità a scapito della stabilità.
Il mito della meritocrazia
Sentiamo spesso che chi ce la fa è solo più bravo o più intraprendente. È una versione comoda della realtà. Il successo imprenditoriale non è frutto solo di talento: dipende da capitale, incubatori, relazioni e da un quadro normativo favorevole. La meritocrazia, quando diventa unico argomento, serve più a consolare che a spiegare.
Mobilità sociale e lavoro: i numeri che disturbano
La mobilità sociale è stagnante nelle società avanzate. Chi nasce in famiglie con poche risorse ha molte meno probabilità di scalare la piramide economica. Qui l’età c’entra fino a un certo punto: pesa di più la struttura delle opportunità. La formazione può essere ascensore sociale, ma solo se la scuola primaria e secondaria funzionano, se ci sono collegamenti veri tra università e mercato, e se l’orientamento lavora sul serio.
Lavoro atipico e politiche sbagliate
La diffusione dei contratti atipici non è soltanto effetto della digitalizzazione o di scelte aziendali. Anche scelte fiscali e previdenziali rendono più costoso assumere stabilmente, spingendo verso formule flessibili. Il welfare non ha seguito i nuovi percorsi di carriera: così la flessibilità diventa precarietà. Serve ripensare incentivi e tutele, per dare protezione anche a chi lavora fuori dagli schemi tradizionali.
Tecnologia: opportunità e inganni
La tecnologia apre possibilità — lavoro da remoto, nuovi mercati — ma non garantisce benessere automatico. Senza regole e investimenti mirati, l’innovazione può amplificare le disuguaglianze. Chi decide le regole e come orientare gli investimenti determina chi guadagna e chi resta indietro.
La retorica della responsabilità individuale
Dire “se vuoi ce la fai” funziona come narrativa morale, ma non basta. L’impegno personale conta, certo, ma non sostituisce scuole di qualità, servizi per la cura, trasporti funzionanti e politiche abitative. Gli slogan motivazionali non pagano gli affitti né creano reti professionali.
Cosa fare — proposte concrete
1) Formazione integrata. Collegare scuola, università e impresa con percorsi che non siano solo tecnici: servono competenze trasversali, orientamento efficace e stage strutturati co-progettati con le aziende. Investimenti pluriennali e aggiornamento dei docenti sono fondamentali. 2) Regolazione del lavoro più equa. Bilanciare flessibilità e protezione: garantire a chi ha contratti atipici accesso a previdenza, sussidi legati alla carriera e percorsi di riqualificazione. Incentivi sbagliati vanno rivisti. 3) Infrastrutture sociali e politiche urbane. Casa, trasporti e servizi di cura incidono profondamente sulle possibilità di investire in una carriera. Interventi mirati sul territorio riducono gap geografici. 4) Misurare quello che conta. Valutare le politiche con indicatori di outcome: occupabilità, qualità contrattuale, mobilità sociale reale. Senza numeri affidabili, ogni intervento rischia di restare simbolico. 5) Responsabilità collettiva. Spostare il focus dalla colpa individuale a responsabilità istituzionali e aziendali. Le imprese dovrebbero essere valutate anche per l’impatto sociale che generano, non solo per i profitti.
Perché la categoria “generazione” inganna
Molti usano “generazione” come un bollino che racchiude presunte caratteristiche condivise. È comodo per campagne di marketing o per titoli ad effetto, ma perde di vista le differenze reali: età, luogo, settore professionale, tipo di contratto e storia familiare segnano percorsi molto diversi. Fare di tutta l’erba un fascio significa rendere più difficile capire chi ha bisogno di quale intervento.0